BELFORTE DEL CHIENTI (Macerata) – Dalla giornata che ha visto l’apertura ufficiale del Campus di Simonelli Group, riportiamo l’intervento di apertura che è stato curato da Antonio Calabrò. Calabrò (1950) è Senior Vice President Affari Istituzionali e Cultura di Pirelli e Direttore della Fondazione Pirelli. È Presidente di Museimpresa e della Fondazione Assolombarda.
È Vicepresidente dell’Unione Industriali di Torino, Presidente dell’Advisory Board Territoriale di UniCredit Lombardia e membro dei board di numerose istituzioni e società (Liuc/Libera Università di Castellanza, Symbola, Nomisma, Touring Club, Fondazione Pier Lombardo, Orchestra Verdi, Milano Musica, Fondazione Unipolis, ecc).
Giornalista e scrittore, ha lavorato a L’Ora, Il Mondo, la Repubblica, è stato direttore editoriale del gruppo Il Sole24Ore e ha diretto La Lettera finanziaria e l’agenzia di stampa ApCom.
Tra i suoi ultimi libri: “Orgoglio industriale”, “Cuore di cactus”, “La morale del tornio”, “I mille morti di Palermo”, “L’Impresa riformista”, “Oltre la fragilità” e “L’avvenire della memoria”. Insegna all’Università Cattolica di Milano.
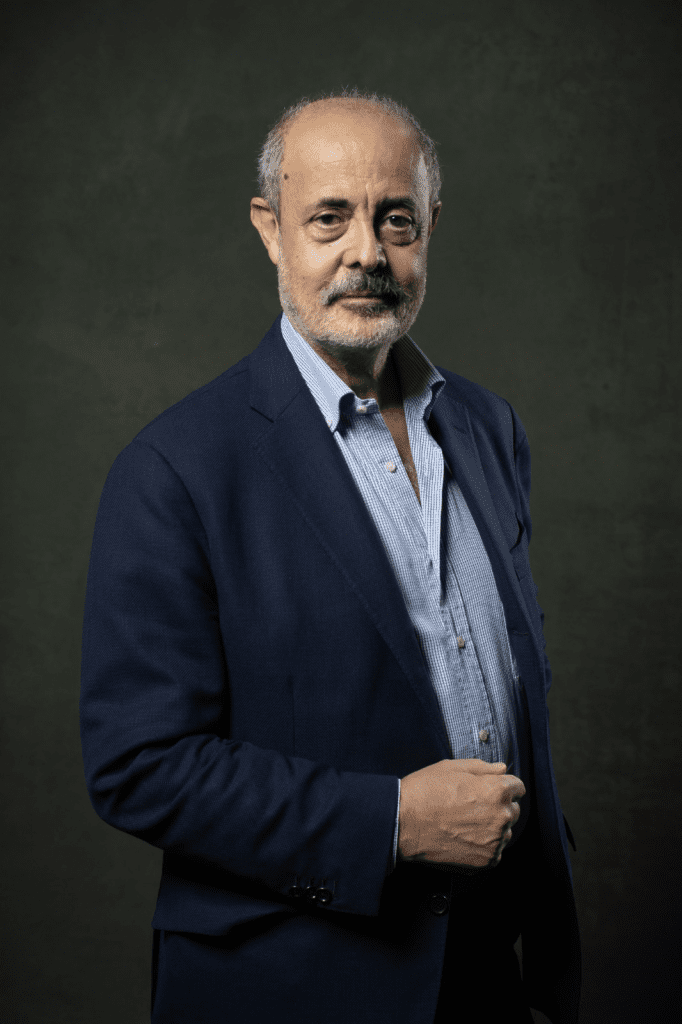
Antonio Calabrò, uno sguardo sul concetto di cultura d’impresa
“Un grazie a Simonelli Group che mi ha invitato e a tutti i ragazzi che sono qui presenti. La citazione a Shakespeare è merito suo e io l’ho soltanto ripresa. E’ il futuro nelle mani delle nuove generazioni: credo che nella responsabilità di fare impresa, oggi in tempi variabili più che in altre condizioni, lo sguardo sulle nuove generazioni sia essenziale.
E non per fare retorica giovanilistica, ma proprio perché dentro i paradigmi dello sviluppo sostenibile, la capacità di costruire nuove conoscenze, è fondamentale.
Shakespeare dovrebbe essere una lettura obbligatoria per chi governa un’impresa: al suo interno si trovano passioni, tormenti, potere, perversioni del potere e possibilità della speranza.
Il futuro è nelle vostre mani
D’altra parte la stessa idea sta dentro il Next Generation EU, nei soldi trovati dall’Europa per rispondere alla pandemia. Qui c’è un’indicazione strategica di lungo periodo, fondata su due elementi: il primo è la salute come asset dello sviluppo sostenibile e il secondo, l’Europa come soggetto, che andando a prendere sul mercato le risorse, per la prima volta mutualizza il debito. Progetta il futuro dei prezzi facendosi carico degli interessi convergenti dei singoli Paesi. Un po’ in ritardo, di fatto. Perché è quello che già negli anni ’80 Charles De Gaulle aveva pensato con l’Eurobonus.
Europa come soggetto politico ed economico che costruisce, grazie alla sua autorevolezza, il soggetto economico tra i più forti al mondo, un progetto comune di sviluppo.
Le cose che abbiamo visto mi fanno venire in mente un modo di raccontare questo Paese. Andiamo all’inizio del 1980, quando esce in Italia un libro pubblicato da Garzanti, scritto da Alberto Arbasino e che ha fatto molto scalpore. Il titolo è “Un Paese senza“, scritto negli anni ’70, drammatici per la politica italiana e durante i quali il paradigma degli anni di piombo non è sufficiente per descrivere cosa stesse succedendo. Perché gli anni ’70 sono anche quelli della riscossa della crisi energetica tra il ’70 e il ’74, del referendum sul divorzio, in cui si manifestano i diritti civili, in cui nelle piazze italiane e nel dibattito pubblico le istanze femministe segnano una prima partenza.
Arbasino coglie i punti della crisi: il Paese senza è privo di coscienza civile, memoria, responsabilità sociale condivisa, un Paese senza progetto comune. Corretta lettura, ma insufficiente. Perché probabilmente già gli anni ’70 e il corso della nostra storia, ci diranno che nella piena consapevolezza delle ombre, è necessario raccontare un Paese con: intraprendenza, senso di responsabilità, capace di progettare, dentro le sue contraddizioni. Un Paese con una cultura, che subito dopo la grande crisi del Covid, in due anni è capace di crescere di quasi l’11%, con un ritmo di sviluppo che questo Paese ha conosciuto soltanto negli anni del boom economico.
Una parte è a ribasso, ma un’altra dà una risposta di sviluppo di lungo periodo strutturale, di una tendenza delle aziende italiane, che è maturata tra il 2007 e il 2008 e si è incentivata a metà del decennio successivo a utilizzare bene le opportunità messe a disposizione dagli stimoli fiscali dell’industria 4.0 per innovare per investire, per conquistare i mercati e avviare cioè, attraverso le nuove tecnologie e riorganizzazione dei modi di produrre, sul legame con il territorio, sulle prospettive e i mercati internazionali, a valorizzare una capacità specifica della nostra impresa.
Antonio Calabrò: “Essere capaci di fare, partendo dai territori, in uno sviluppo di lungo periodo guardando con attenzione ai mercati internazionali e in modo originale alla qualità.”
Valorizzando quel 10.9% di crescita, che è anche la possibilità di non infilarci nella recessione. dall’ultima previsione di Banca Italia, dicono che la crescita possibile è del 0,6%, che seppur minima, è pur sempre crescita. La recessione potrebbe non essere tema del dibattito pubblico: ma non può non essere tema delle politiche di governo quello di insistere sugli elementi di forza di continuità del nostro Paese.
Ci tocca raccontare lo sviluppo italiano nella piena consapevolezza delle ombre, dei limiti e dei difatti che segnano la nostra storia, senza però fermarsi a questi. L’Italia merita un racconto migliore di se stessa. Senza indulgere in un facile ottimismo, ma insistendo sugli elementi di qualità.
Quali sono? In tanti conosciamo la definizione di Carlo Maria Cipolla sullo sviluppo italiano: “Gli italiani abituati sin dal Medioevo a produrre all’ombra dei campanili, cose belle che piacciono al mondo”.
La storia di Simonelli Group e di tante altre imprese sono la dimostrazione che quella definizione non è una teoria economica, ma è un racconto da cronista sofisticato dell’andamento della produzione industriale e dei rapporti tra impresa e territorio
Cose belle: che vuol dire nell’accezione di Cipolla? La bellezza è un dato estetico e naturalmente si lega al design ma ha molto a che fare con la qualità e la relazione di positività di rapporto. Tutto ciò che Symbola raccolta da anni sui 100 casi eccellenti, sulle ragioni per cui l’Italia è nelle condizioni di stare sul mercato internazionale. Cose belle è una misura del fare le cose, della responsabilità, del “su misura“. E’ un punto di forza dell’industria italiana. Non soltanto la moda e l’arredo, ma la metalmeccanica, la meccatronica, il saper fare impianti, macchine utensili e industriali.
Il su misura della risposta a mercati che chiedono proprio a noi prodotti specifici. Una nuova acciaieria, una nuova linea di montaggi sofisticata, digitale, con tutti gli elementi per poter essere adattabile alle richieste della committenza. Se si chiede a una grande azienda americana, cinese o tedesca, con meccanici fantastici, di realizzare un impianto di produzione su misura, che faccia un tot di pezzi e sia flessibile, nessuno lo saprà fare. Soltanto noi ci riusciamo.
Questa è uno degli asset che spiegano quel 10.9%. Ho visto oggi nelle linee produttive di Simonelli Group, quell’idea della misura, perfettamente testimoniata delle macchine che sanno usare. E che nessun altro sa fare. E‘ il nostro vantaggio: piccola serie di grande qualità. Bellezza è quella che sappiamo usare anche strumentalmente per certificare la qualità e la attrattività dei nostri prodotti industriali.
Ho rubato una citazione a Ermete Realacci, da un vecchio documento pubblico della storia italiana, il costituto della città di Siena, 1309. La Costituzione di Siena, città di mercanti, di banchieri, di manifattori, di imprenditori agricoli che trasformano i prodotti. Retta da un’aristocrazia del denaro, non di spada e soltanto in parte di norma.
Il Costituto dice, acciocché i poveri capiscano: “Chi governa deve tenere massivamente in conto la bellezza, per diletto e allegrezza ai forestieri e per prosperità e accrescimento dei cittadini.”
Oggi lo chiameremo attrattività e la misureremmo con il PIL o con l’indice del benessere sostenibile elaborato dall’Istat che non viene però applicato con tutte le conseguenze del caso.
Perché quei banchieri che governano la città insistono sulla bellezza?
Pensano alla bellezza dei loro palazzi, delle loro chiese che sono certificato di qualità delle loro tratte bancarie e delle loro produzioni. E’ quello che garantisce a tutti coloro che entrano in rapporto con Siena, che i prodotti della città, il denaro e i certificati sugli scambi sono attendibili perché per legge è capace di realizzare quelle chiese quei palazzi, che raccontano una straordinaria capacità di parlare al mondo attraverso canoni estetici che diventano poi criteri economici.
La conferma la avremo a Firenze con Cosimo dei Medici in un altro dettaglio: un quadro, “L’adorazione dei Magi” di Gentile da Fabriano agli Uffizi dalla cappella di Palazzo Strozzi. Il committente chi è? Si chiama Paolo Strozzi, che fa il produttore di tessuti. Con quel quadro vuole dire al mondo che quello è il catalogo dei suoi tessuti: la bellezza come funzione economica.
La capacità di leggere un processo economico raffigurandolo nel modo più elegante, profittevole, prestigioso, del momento: il quadro di un grande pittore.
Questi elementi noi ce li portiamo dentro nelle nostre imprese, che hanno la stessa capacità. Senza commissionare quadri e realizzare piazze, ma costruendo nel nostro tessuto economico imprese che di quelle caratteristiche – qualità, misure, design – fanno misure essenziali di competitività.
I ragionamenti che facciamo su cultura, sostenibilità e elementi della bellezza, non sono atti di mecenatismo, ma asset di competitività del nostro Paese
Quella storia non solo è un asset di competitività, ma è originalità. Si può copiare tutto, tranne due cose: la nostra storia e la nostra consapevolezza di questa caratteristica originale, lascito culturale di lungo periodo che attraverso le imprese, università, dati culturali, passiamo di generazione in generazione.
Vale la pena di ricordarci che parlare di cultura di impresa è parlare di cultura in generale. La cultura è Gentile da Fabriano, la grande tragedia di Alfieri, l’allegoria del buono e cattivo governo, la cultura è tutto quello che abbiamo studiato al liceo classico. Ma le imprese raccontano che la cultura è anche la chimica (il premio Nobel per la chimica a Giulio Natta ne è la conferma) è la bellezza della chiave a stella, la lega speciale con cui si fanno gli alberi e le vele di Luna Rossa.
La cultura è un contratto di lavoro ben scritto perché definisce la relazione tra parti che progettano insieme in fabbrica il futuro della qualità e dello sviluppo di un territorio. La cultura è il bilancio che ha il coraggio, l’intelligenza progettuale, di mettere insieme i dati economici, di sostenibilità nella testimonianza che questi siano fondamentali nella scrittura dei dati economici. Se non avessimo incorporato nel nostro modo di lavorare gli elementi della bellezza e della sostenibilità non scriveremmo quelle poste dell’attivo in molti bilanci delle nostre imprese.
E’ un elemento di riflessione che affido a voi. Penso che l’impresa sia un soggetto sociale, che ha responsabilità, una macchina che produce profitti, perché senza non c’è risorsa di investimento possibile e innovazione da finanziare. La domanda non è se producano profitti, ma come lo fanno. In questo vale la pena ricordarci un’altra lezione che viene fuori dalla risposta che l’Italia ha dato alla crisi finanziaria del 2008 e poi del debito sovrano del 2010.
Cioè rivalutare l’economia reale, sapere che c’è un modo di fare profitti che è quello delle nostre imprese di manifattura e poi di servizi e poi di finanza che lavora sulla qualità dello sviluppo, sui posti di lavoro messi in movimento, sul benessere diffuso, sulla possibilità di avere risorse per investire nel futuro.
La rivalutazione dell’economia reale è la consapevolezza dell’importanza della relazione sociale per produrre dei profitti ed è un altro degli elementi che connota particolarmente le nostre imprese. Siamo di fronte a un passaggio culturale largo: dal primato del valore economico (profitti e costi di borsa) al primato di quelli che si chiamano gli stakeholders values. Gli interessi dei dipendenti, dei fornitori, delle comunità su cui l’impresa agisce. Questo passaggio trova noi italiani inclini, per la storia alle spalle dei legami con il territorio, del gusto per la bellezza che ha una forte connotazione sociale. Le nostre aziende hanno pensato sociale, largo, futuro.
Sul pensare futuro un’ultima osservazione
Le nostre imprese stanno dentro un mondo in grande cambiamento. A lungo abbiamo pensato che la platea migliore fosse la globalizzazione spinta all’estremo. Chi sapeva leggere gli andamenti del flusso economico sapeva che confidare troppo su questo fenomeno senza regole e criteri, sul free trade, avrebbe portato ad aumentare gli elementi della disuguaglianza e l’inaccettabilità della globalizzazione.
Il Covid e il tema dei trasporti internazionali, ci ha insegnato che le catene lunghe per la rifornitura erano troppo fragili per reggere. E l’aver dislocato altrove la produzione in luoghi che costava poco il lavoro e i vincoli sociali, era un errore fondamentale, perché metteva la capacità produttiva di un continente trasformatore con poche materie prime, come l’Europa in una posizione di fragilità.
Siamo in una stagione in cui ripensiamo la globalizzazione, che non è conclusa: le economie internazionali sono ancora connesse ma vanno attuati nuovi meccanismi di relazione. Rethinking globalization: siamo in corso di questo processo che ha come conseguenza il bad shoring, il ritorno alla produzione lì dove ci sono mercati e competenze.
Dove? In Italia, dove abbiamo molte competenze, in Europa, accorciando le catene di fornitura e rendendo più semplici i rapporti con il mercato.
Ma per poterlo fare, all’Europa e all’Italia dentro l’Europa, nessuno vince da solo. Non è affatto vero che un uomo è un’isola, soprattutto in termini di economia. Ripensare tutto questo, sapendo che per poter governare il bad shoring è necessario avere politiche industriali europee entro cui il nostro Paese deve stare, che insistono su alcuni aspetti.
La posizione strategica dell’Europa che ha molto a che fare con la rifornitura dell’energia e delle materie prime, con le strategie che fanno riferimento alla ricerca scientifica, con strategie politiche che stimolino le competitività delle imprese europee e poi italiane dentro l’orizzonte europeo.
L’Europa da questo punto di vista si sta muovendo nonostante limiti e contraddizioni in una direzione positiva: il fatto che si stia pensando a Bruxelles a un fondo comune per le forniture energetiche e di materie prime è già un’indicazione. Confindustria rilancia l’intuizione di Charles De Gaulle degli Eurobond.
C’è chi preferisce gli aiuti di Stato che per noi italiani sarebbero devastanti, i tedeschi possono contare su una disponibilità fiscale che noi non abbiamo. L‘idea di un fondo comune è l’elemento con cui fare i conti.
Dentro una condizione di crisi senza spaventarsi per essa. 1954, il bellissimo discorso di Jean Monnet, uno dei padri dell’Europa: si farà l’Europa nelle crisi e quello che sarà, sarà la risultante delle risposte date alle crisi. Covid, guerra, globalizzazione da ripensare tra contraddizioni e limiti a cui faticosamente l’Europa sta cercando di fornire una risposta.”















