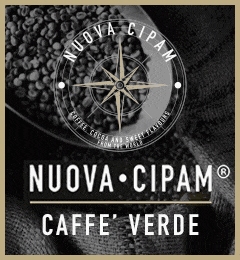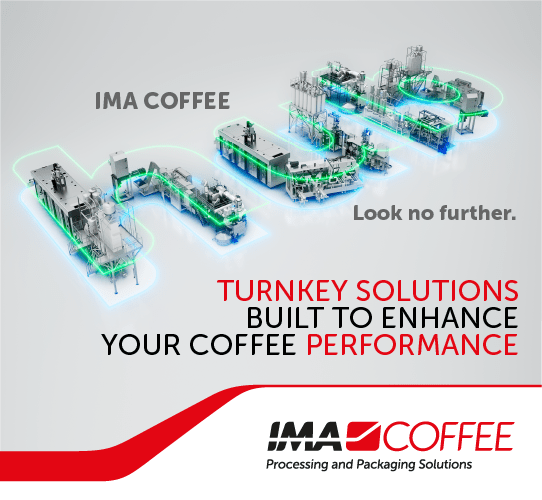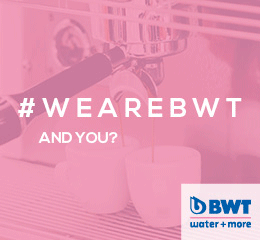Fresco dell’esperienza a SIGEP, parla Alessio Baschieri, tecnico di filiera, con il ruolo di agire in piantagione per portare avanti progetti di Cooperazione finanziati anche da Governi. Un lavoro che svolge da ormai 27 anni.
Baschieri specifica: “Ovviamente in questo arco di tempo c’è stata un’evoluzione: attualmente opero in Kenya in tre progetti. A SIGEP abbiamo portato alcuni beneficiari del progetto ARABIKA: lavoriamo con 21 cooperative ed abbiamo creato 7 laboratori, formando gli assaggiatori, insegnando ad ottenere la qualità già dove si trasformano le ciliegie, in impianti progettati e realizzati dal fu impero britannico, vecchi ma ancora performanti.
Mi occupo di eliminare i difetti dal prodotto in modo che abbia la possibilità di essere commercializzato in filiera diretta, saltando gli intermediari locali che pagano poco, ma subito e non richiedono qualità. Il caffè deve essere il più pulito possibile, in modo da ridurre il rischio di imbattersi in chi tenta di ottenere sconti eccessivi. In Kenya questa materia prima finisce storicamente all’asta e viene pagata poco.
Per fare uno scatto in avanti, bisogna proporre un prodotto senza difetti, portare questi campioni nel mondo e nelle Fiere, far incontrare i coltivatori ai crudisti e torrefattori. A questo poi dovrebbe seguire tutta la parte commerciale, sulla quale continuo ad offrire la mia assistenza.”
Baschieri: “Ci sono due problemi in Kenya, che negli altri Paesi d’origine esistono meno”
“Tutto il caffè viene venduto all’asta, all’interno di un sistema creato ai tempi in cui era colonia inglese; l’età media di chi lavora nella filiera è molto vecchia. Parliamo di persone nate quando ancora c’era uno stretto legame con il Regno Unito.
In Kenya il caffè è inteso davvero come un prodotto crash crop, e quindi non destinato al consumo locale ma che segue una semplice logica: se il caffè rende, allora bene; altrimenti viene tagliato. Non c’è un’identità nel coltivatore, la società non è strutturata attorno alla coltivazione del caffè, gli agricoltori non hanno una identità di cafficoltori e la compravendita rispetta ancora i vecchi dettami dell’impero britannico: chi se ne occupa è anziano e spesso non incline a usare canali social, il web e a cambiare idee o prospettive.

Per queste condizioni particolari, anche se siamo in grado di fare un prodotto di alta qualità, avremmo bisogno che avvenga un cambio generazionale da una parte e un’apertura sanificante che arrivi dall’esterno. Questo è quello che stiamo facendo tramite i progetti di cooperazione.
“A SIGEP quest’anno, abbiamo presentato questo nostro tentativo di mettere in mostra il caffè, dando un piccolo esempio che eventualmente i vicini possono seguire”
“Già da 16 anni seguo anche la partecipazione alle fiere dei vari progetti. Questa edizione siamo arrivati con cinque Paesi a SIGEP grazie all’ICE (Istituto per il Commercio Estero) e la cosa bella è l’essere riusciti a sfruttare questo momento di incontro: nel padiglione c’erano 13 paesi produttori di caffè e cacao, otto coordinati da IILA (Istituto Italo Latino Americano), tra Centro America (Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Haiti) e Sud America (Venezuela Colombia ed Ecuador) e i nostri cinque dall’Africa (Costa d’Avorio, Uganda, Tanzania, Kenya e Etiopia).
Nell’area del caffè, grazie alla collaborazione con alcune aziende particolarmente sensibili come La Marzocco, XLVI e Markibar, ogni paese era dotato di macchina espresso per servire ciascuno il proprio caffè. Ma abbiamo proposto anche percolati e moke. Questa vicinanza ha fatto sì che chi era interessato, incuriosito, potesse trovare nei due stand un’intera proposta africana oppure del centro-sud America.
Qui abbiamo organizzato dei tavoli di cupping e fatto collaborare queste due aree di produttori, che hanno potuto e voluto scambiarsi a vicenda competenze ed esperienze di assaggio, creando una fratellanza per me davvero splendida da vedere. Per questo posso affermare che questa esperienza in Fiera ha rappresentato un grandissimo risultato, in quanto è riuscita ad unire coltivatori di diverse parti del mondo, in un dialogo comune.
Assieme a Biocuba, sempre nel Sustainability Village, siamo stati gli unici presenti con dei farmer in queste manifestazioni: i coltivatori non sono quasi mai presenti in questi momenti, almeno non coloro che lavorano nei campi. Questa partecipazione invece è fondamentale, perché al loro ritorno il racconto dell’esperienza nella propria comunità è importantissimo per comprendere il Paese di destinazione del loro prodotto, in un’ottica più di collaborazione che di mera tentata vendita.”
I torrefattori si sono dimostrati interessati?

“All’interno del mio lavoro vi è anche la creazione di rapporti tra l’industria e le cooperative, spesso fungendo da facilitatore per lunghi periodi. In oltre vent’anni di esperienza ho anche tentato di organizzare gruppi di acquisto diretti con quei torrefattori che si erano mostrati particolarmente sensibili ai temi etici.
Ebbene, con i torrefattori italiani non ho avuto molta fortuna: in genere, non sono inclini ad assumersi il rischio dell’acquisto diretto in piantagione, di affrontare eventuali difficoltà nella gestione della logistica, nel dover superare la barriera del dialogo con gli acquirenti in una lingua e una forma mentis differenti.
L’idea di investire un po’ al buio – il caffè va pagato con largo anticipo -, con il rischio che poi una volta arrivato in Italia il verde non corrisponda alla qualità acquistata, non è da molti condivisa. Il torrefattore italiano vuole acquistare un prodotto già sdoganato e così avere una persona identificata alla gestione del rischio esterna alla propria realtà. Esattamente l’opposto di ciò che fanno i roasters anglosassoni ed asiatici, che invece desiderano andare ad acquistare direttamente nei campi.
Perché? A parte per una questione culturale, è in primis il loro consumatore finale ad attribuire un forte valore alla filiera diretta. Il consumatore italiano al contrario, anche solo se si alza di qualche centesimo la tazzina, scende in piazza.
Magari esce dal bar e non si ricorda neppure la marca di quello che ha bevuto. Il torrefattore ha contribuito a costruire una modalità di vendita che si fonda sul brand conosciuto, senza che si senta più neppure il bisogno di chiedersi cosa ci sia effettivamente dentro, affidandosi alle onde di comunicazione generalizzate e omogeneizzate. Ora ad esempio vanno di moda la parola sostenibilità e la certificazione B Corp.”
Quindi SIGEP, segna un bilancio positivo?
“Sì, anche se abbiamo commesso un errore in Fiera: ci siamo affidati totalmente al format che avevamo ideato insieme agli organizzatori di SIGEP, del Sustainability Village, che ha messo insieme i produttori di caffè e cacao vicini per dar loro un’identità precisa e creare un movimento unico e importante. Così mi sono concentrato nell’organizzare la programmazione, trascurando però la parte dedicata al coinvolgimento di un pubblico di clienti maggiore.
Le torrefazioni che vengono in Fiera lo fanno spesso in maniera statica, restando ciascuno nel proprio stand per incontrare clienti e agenti: non avevano per questo le funzioni aziendali potenzialmente interessate a partecipare ai nostri incontri, come i responsabili acquisti e il controllo qualità.
Per cui quando siamo stati pronti con il nostro programma, ci siamo ritrovati con una partecipazione limitata: è stato comunque un grande successo e abbiamo testato questo format che ha grandissime potenzialità. Chi è tornato a casa lo ha fatto sicuramente motivatissimo e quando ci ritroveremo in Kenya nelle cooperative, potrò contare su dei potenziali leader, delle guide che daranno l’esempio agli altri, in particolar modo rappresentati dalle donne.
Come mi piace spesso ripetere, il caffè è donna, da quando lo si coltiva, lo si raccoglie, lo si seleziona.
L’uomo solitamente si occupa di intascare i soldi. Ed ecco perché è importante supportare le donne alle origini: abbiamo per questo formato tantissime ragazze in Kenya. In Guatemala in particolare abbiamo lavorato con 3 cooperative ottenendo risultati eccezionali, a tal punto che abbiamo ricevuto diversi riconoscimenti ufficiali.”
Ci sono altri progetti che Baschieri svolge alle origini
“Sono specializzato nel lavoro con gruppi indigeni in foreste primarie e questo significa, nella pratica, che mi assicuro che i farmers restino nelle foreste e possano continuare a vivere secondo le loro consuetudini e radici culturali. Solo in questo modo possiamo contrastare la deforestazione.
La parola foreste fa venire alla mente certamente l’EUDR, e ci sono delle importanti analogie: per avere un prodotto certificato come idoneo per l’EUDR, ci vuole una carta di identità e tutto questo può solo partire dal fatto che quel lotto di caffè ha un nome e un cognome, innanzitutto. Nelle tribù indigene la proprietà della terra viene tramandata oralmente, e la presenza di un catasto va contro gli interessi di chi se ne può appropriare riuscendo ad interrompere questa catena familiare. Una foresta non vissuta è terra da disboscare in mano al più forte o prepotente.
Per questo sto insistendo nel rafforzare l’identità di popolo nelle nuove generazioni, affinché studino all’estero per poi tornare in casa con nuove competenze per dare continuità alle loro origini tribali. In Amazzonia ad esempio ci sono diversi progetti che hanno avuto grande successo.
Sono tecnico anche di tostatura, mi reco nelle torrefazioni a risolvere diversi problemi sui profili: il problema di saltare da una materia prima all’altra, soprattutto oggi che il prezzo è alle stelle, è quello di mantenere il più possibile costante il risultato finale gustativo in tazza. Si può fare tanto, modulando le curve di tostatura.
Credo molto anche nello sviluppo del mercato locale e sempre alle origini cerco di fare evolvere la torrefazione e la vendita del caffè localmente, soprattutto grazie al coinvolgimento delle donne. In Guatemala un gruppo di donne si è organizzato così bene da riuscire a vendere sul mercato locale tutto il caffè destinato all’esportazione. Sono per me grandi soddisfazioni, oltre ad un grande divertimento.“
E prossimi appuntamenti?
“SIGEP è stato un primo test. Una fiera che è ben disposta da sempre ad ospitare questo format, da quando accolse nel 2014 il World of Coffee, insieme ad una grossa parte di produttori. All’interno di un’economia generale e considerando la partecipazione alle Fiere come progetto di cooperazione, sto strutturando meglio la presenza di un certo numero di Paesi produttori. Per il momento non me la sento di sviluppare altre idee.
Sicuramente si dovrà lavorare meglio sul coinvolgimento di nuovi clienti e dovremo riuscire a implementare gli scambi interni, uscendo dalla pura logica dell’empatia. Ho trovato il Sustainability village vincente: le persone arrivavano, scoprendolo direttamente in Fiera. Si è dimostrato molto attrattivo. Speriamo nei prossimi mesi di avere la possibilità a come ottimizzarlo: tutto dipende dall’approvazione dei nuovi budget.
Ad esempio, il progetto ARABIKA in Kenya termina a marzo e non sappiamo se continuerà. ICE ha bisogno di una programmazione annuale e anche IILA ha diversi vincoli, nonostante la collaborazione sia già rodata e prosegua da anni.”
Ma in questa sua lunga esperienza sul campo, Baschieri, c’è stata un’evoluzione?
Baschieri: “Ho visto che siamo tutti molto maturati come persone: nonostante le varie crisi che ci hanno colpito, siamo migliorati, diventando più collaborativi e lasciando da parte gli individualismi. Siamo consapevoli oggi che se perde il mio vicino, perdiamo anche noi.
Il sogno di un tecnico di piantagione è di poter aver dei progetti decennali: il caffè è un crop soggetto ad una stagionalità di raccolta annuale, per cui dovrei avere a disposizione diversi anni per vedere i primi risultati, più un altro periodo di tempo per migliorare sui difetti ed educare le persone.
Il primo anno arrivo per controllare la situazione iniziale e da qui formulare una proposta nata dalla mia valutazione.
Le proposte devono essere accolte dai beneficiari, non possono essere imposte con la forza dall’alto, altrimenti sono destinate al fallimento. In seguito si cerca di coinvolgere tutti i soggetti per realizzare insieme gli obiettivi finali. Bisogna porsi sempre con umiltà, nel rispetto delle usanze locali: cerco sempre di imparare i dialetti del posto, per aumentare il livello di empatia, ma ho bisogno di tempistiche prolungate per cambiare le condizioni di povertà verso contesti di valore.
Attraverso il caffè sto modificando dei modi di vivere fossilizzati in consuetudini, quasi sempre collegate a dinamiche di forza sociali. È necessario realizzare il cambiamento con dolcezza, altrimenti si creano strappi che possono creare problemi maggiori di quelli che eravamo stati chiamati a risolvere.
Pensiamo invece che attualmente i progetti prevedono una durata di tre anni – prima era tutto più leggero – : bisogna sperare che le ONG che gestiscono i finanziamenti statali, abbiamo una lungimiranza per poter programmare progetti spezzati, fatti a step così da realisticamente portare a termine i lavori. Non si riesce quasi mai, perché ci sono dei buchi geografici e temporali che rendono un po’ vani gli sforzi.”
Parliamo de L’Albero del Caffè, la torrefazione sua e di sua moglie Antonella Favilla
“È un laboratorio artigianale e nasce per mettere insieme i progetti che ho portato a termine come tecnico in piantagione e la sensibilità di mia moglie nella gestione di progetti sociali: per questo abbiamo coniato il Pay off “Il gusto dell’etica”. Lavoriamo solo caffè biologici nella salvaguardia della biodiversità comprandoli tramite gruppi in una filiera corta.
Una componente importante è la certificazione biologica, che utilizziamo in tre modi: in primis con la certificazione si attua una più ampia valorizzazione della tradizione tribale. L’agricoltura biologica può recuperare delle pratiche ancestrali delle antiche tribù, conoscenze spesso collegate a componenti spirituali; la certificazione dà loro valore agli occhi delle nuove generazioni che spesso le rifiutano o non le riconoscono.
Secondo elemento è il dare ordine al caos che spesso si crea nella gestione da parte della cooperativa, che spesso è disorganizzata e provoca diversi problemi sulla documentazione: la certificazione obbliga invece a tenere in ordine le carte e questo a sua volta porta a delle dinamiche sociali più strutturate, che vi ruotano attorno. Il primo risultato visibile è che non vengono più gettate cartacce e rifiuti per terra: quando questo avviene, allora la strada verso il cambiamento è iniziata.
Terzo punto: davanti a un esame con un valutatore rigido che viene dall’esterno, si crea un appuntamento annuale in cui la comunità fa squadra per superare insieme l’esame.
La vittoria di essere valutati positivamente alimenta lo spirito e l’autostima dell’intera comunità. In quest’ottica il biologico diventa uno strumento utile alla società: i difetti del caffè nascono da problemi sociali di chi lo coltiva o lo lavora e un processo di salutogenesi delle dinamiche sociali porta ad un caffè privo di difetti e di conseguenza con maggiore valore.
Grazie ai progetti di cooperazione, spesso ospitiamo i coltivatori dei progetti e coinvolgiamo anche i nostri clienti in incontri dove si possono raccontare, oltre a crowd funding per finanziare scuole, biblioteche, progetti di alimentazione e tanto altro. Siamo piccoli ma pieni di idee ed entusiasmo.
L’Albero del Caffè racconta le storie delle persone che hanno coltivato il caffè: i nostri clienti ci sono affezionati proprio perché vogliono portarsi a casa quelle vite e farne parte. “